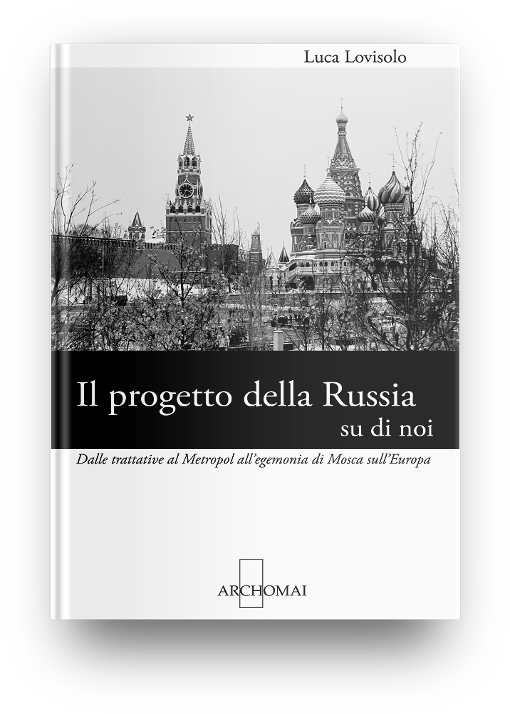I problemi di Cuba sono aggravati dalla pandemia, ma la loro causa è altrove. Le proteste dei cubani e le contro-manifestazioni del regime. L’incapacità del giornalismo italiano di liberarsi dall’adulazione per il castrismo. La sanità cubana crolla sotto la spinta della pandemia. Il governo costruisce cattedrali nel deserto per i turisti, ma i malati di COVID finiscono in ospedali cadenti.
Con la facciatosta tipica del giornalismo politicamente obbligato, numerosi commentatori hanno interpretato le proteste avvenute in queste settimane sull’isola di Cuba come conseguenza della pandemia. La crisi pandemica ha acuito il malfunzionamento dello Stato, ma non è all’origine del problema; non lo è nemmeno l’embargo degli Stati uniti, anche se entrambi i fatti, pandemia ed embargo, vengono indicati come causa di tutti i mali dell’isola. Causa primigenia dello scontento dei cubani è il regime che governa il Paese da sessant’anni. Il sistema sanitario cubano ha dei meriti, rispetto a quello di altri Paesi equivalenti, i medici cubani sono tanti, ma, soprattutto per quanto riguarda le dotazioni ospedaliere, non è all’altezza dei tempi, come conferma la dottoressa tedesca >Ingrid Hunold, conoscitrice dell’isola e della sua organizzazione sanitaria.
In uno dei tanti servizi andati in onda in questi giorni sulle reti nazionali italiane, un giornalista parlava della sanità cubana come «fiore all’occhiello» del regime. Intanto, però, le telecamere mostravano le immagini di un ospedale in cui si vedevano corridoi in pessimo stato, arredi antiquati, bombole di ossigeno arrugginite e in chissà quali condizioni igieniche, pazienti ammassati che giacevano alla meglio su letti che da noi usavano negli anni Cinquanta. I malati erano rinfrescati, si fa per dire, da un ventilatore su uno scaffale: in quell’ospedale, ai Caraibi, non ci sono condizionatori d’aria.
Cuba si affretta a inviare gruppi di medici in ogni parte del mondo, ma le loro condizioni di lavoro sono state oggetto di un’interrogazione alle Nazioni unite e di una denuncia di Human Rights Watch: sfruttamento, divieti di contatto con le popolazioni locali, controllo politico e incoraggiamento della delazione, se un componente delle missioni avesse atteggiamenti critici verso il regime. A ciò si aggiunge il sospetto che queste missioni servano al governo per ottenere in cambio valuta estera (o petrolio, nel caso dei medici inviati in Venezuela), sebbene vengano generalmente lodate come attività umanitarie senza fine di lucro, conferma il giornalista tedesco Jan D. Walter di >Deutsche Welle.
Il sistema sanitario di Cuba è macchiato da tutte le ipocrisie che chi conosce i regimi comunisti ritrova in ogni luogo in cui questi hanno regnato. Oggi vacilla sotto la spinta del COVID, ma la causa prima è la decennale malagestione della cosa pubblica, non la pandemia.
Embargo a Cuba: gli effetti reali
Quanto all’embargo e alle altre misure restrittive imposte dagli Stati uniti ai danni di Cuba, è vero: sin dal 1823, anno della Dottrina Monroe, gli Stati uniti esercitano su tutta l’America latina un controllo che riduce i Paesi di quella regione a Stati a sovranità limitata. È un’azione molto simile a quella che la Russia compie sui Paesi dell’ex Unione sovietica e vorrebbe compiere anche sul resto d’Europa, cioè su di noi (continuando così, ci riuscirà presto). Queste influenze improprie devono cessare, ovunque.
L’embargo a Cuba causa serie difficoltà, nelle importazioni dagli Stati uniti, è fuor di discussione. Cuba importa da altri Paesi, però. L’embargo statunitense complica l’import anche da Stati terzi, a certe condizioni, ma non lo rende impossibile: tra i numerosi fornitori internazionali di Cuba c’è l’Italia, che verso l’isola ha esportato, nel 2020, per 187 milioni di euro (fonte: >InfoMercatiEsteri, dati del governo italiano). Nell’elenco delle esportazioni spiccano i macchinari (60 milioni), i prodotti chimici (32 milioni), le apparecchiature elettriche (20 milioni). Le cifre sono relativamente piccole, ma attestano che verso Cuba non è tutto bloccato.
I mali che i cubani lamentano oggi hanno ben poco a che vedere con l’embargo. Non entriamo neppure nella questione ideologica e nella pur tragica situazione dei diritti fondamentali, limitiamoci all’asettica analisi dei meccanismi di funzionamento dello Stato e dell’economia. Se gli Stati uniti liberalizzassero le esportazioni e gli scambi valutari con Cuba, i vantaggi non ricadrebbero sui cubani, ma sul regime che li ha ridotti nelle condizioni di oggi, perché questa è la logica dell’economia pianificata. Quando, in Unione sovietica, salì al potere Michail Gorbačëv, la popolazione si avviava a uno dei peggiori periodi di carestia. Cosa decisero, Gorbačëv stesso i responsabili economici di allora?
Anziché stimolare le produzioni di beni di prima necessità, modernizzare le reti di distribuzione, guidare la nascente economia privata, investirono le risorse rimaste nell’ammodernamento della produzione di macchine utensili. Sì, la produzione di macchine utensili!, come se i sovietici, che alla fine degli anni Ottanta facevano code di mezze giornate per tentare di comprare un salame e un panetto di burro (e nelle città di provincia erano razionati con la tessera annonaria), avessero potuto mettere in tavola, in loro vece, un tornio polimandrino e mangiarselo tra due fette di pane della settimana prima.
Lo stesso accade a Cuba. I cittadini si chiedono perché vivono in case cadenti, mentre lo Stato trova i soldi per costruire lussuosi hotel turistici. La spiegazione è che negli hotel arrivano i turisti, pagano con valuta forte, mettono in moto l’economia e alla fine anche il singolo cittadino ne beneficia. È lo stesso argomento con il quale i dirigenti sovietici rispondevano a chi, sbalordito, chiedeva loro perché puntassero sulle macchine utensili, anziché sulle forniture di beni di prima necessità ai cittadini: se noi costruiamo buoni torni e buone frese, pensavano, le esporteremo meglio e tutte le industrie che utilizzano queste macchine produrranno con più qualità. I benefici ricadranno su tutta la filiera e, giù giù, fin sul cittadino. Una genialata!
«Economia informale?»
La genialata non funzionò, e non funziona nemmeno a Cuba con gli hotel, anche quando i turisti torneranno, dopo la pandemia: prima che il vantaggio generato da tali astruse pensate diventi concreto per il cittadino, che si trova in fondo alla catena di generazione del valore, il cittadino crepa, di fame o di COVID. Se sopravvive, quel valore non lo vede comunque, perché, prima di arrivare nelle sue tasche, alimenta i mille rivoli della burocrazia e della corruzione. E lui, il cittadino, si accontenta dell’…economia informale, come l’ha definita con pudore un cronista. Economia informale? Il suo vero nome è mercato nero.
Cambiargli definizione è un modo per imbellettare la scomoda realtà, che è questa: i cubani beneficiano del turismo non perché lo Stato ne distribuisce i proventi ai cittadini, ma perché si arrabattano con i traffici di valuta, con le vendite in nero di piccoli oggetti e con chissà quali altri servigi offerti ai visitatori. Il giornalista le sa, tutte queste cose, ma, per ragioni politiche, non può dirle: non può nemmeno dire che tutto va bene, però, di fronte a migliaia di cittadini che sfidano il governo nelle strade. Dicendo mercato nero, tutti capirebbero: se i cittadini, per vivere, devono ricorrere al mercato nero, cioè all’economia di guerra, significa che il regime è fallito.
Perché negli alberghi costruiti dal regime per i turisti stranieri i condizionatori d’aria ci sono, ma nell’ospedale ripreso dalle telecamere del telegiornale no? Da qualche parte arrivano, i condizionatori, magari proprio dall’Italia, o da altri Paesi che non applicano alcun embargo. I cubani sono stufi di un regime che riesce a importare di tutto, quando costruisce le cattedrali nel deserto per i turisti, ma quando deve rinnovare le infrastrutture sanitarie e le altre installazioni per servire a una dignitosa vita della popolazione, tira in ballo l’embargo e chissà quale altra scusa, e non fa nulla.
La manifestazione a sostegno del regime
La contro-manifestazione organizzata dal regime cubano a proprio sostegno, nei giorni della protesta, non può essere citata per bilanciare le manifestazioni dei cittadini. Una dittatura ha sempre i suoi sostenitori, non di rado rappresentano la maggioranza della popolazione. Le battaglie contro i regimi autoritari non si combattono secondo il principio quantitativo.
Le dittature conculcano la libertà, ma distribuiscono anche vantaggi. Troveranno sempre qualcuno disposto a sostenerle urlando per le strade, perché teme di perdere i piccoli privilegi, il piccolo potere che il regime gli concede in cambio della fedeltà; se poi il regime non trova nessuno, sa come fare a riempire le piazze a comando. Non si possono mettere le due parti sullo stesso piano: di qua ci sono i cittadini che protestano sfidando il regime, di là ci sono quelli che lo sostengono, e tutto finisce lì. Il mondo è più complicato di quanto certi cronisti immaginano.
Il punto più basso delle molte cronache delle vicende cubane di queste settimane si è toccato, forse, quando al racconto della crisi dell’isola è stata fatta seguire, nello stesso contesto, una lunga digressione sul campo di prigionia statunitense di Guantanamo. Il campo si trova nell’omonima base militare che gli Stati uniti gestiscono su una porzione di territorio cubano, ceduta loro in locazione perpetua sin da inizio Novecento. Siamo chiari: Guantanamo è una vergogna per l’intero Occidente. Le condizioni di carcerazione sono contrarie a ogni principio riconosciuto. È una di quelle numerose situazioni in cui gli Stati uniti mostrano di predicar bene, in materia di diritti umani, ma di razzolare assai male.
Ciò premesso, Guantanamo non c’entra con la crisi economica e sociale cubana; Guantanamo non incide sul tasso di mortalità e diffusione del nuovo Coronavirus; Guantanamo non ha effetti sul sistema sanitario cubano. Di Guantanamo i cubani se ne infischiano, perché si svegliano la mattina e devono cercare gli espedienti per giungere sani e nutriti fino a sera. Il lungo riferimento a Guantanamo era stato accodato al racconto della triste situazione dell’isola al solo scopo di trasmettere questo messaggio: a Cuba le cose non vanno bene, ma nemmeno gli Stati uniti sono uno stinco di santo. Come per il surreale racconto dell’ospedale, si avvertiva uno stridore assordante tra parole e realtà.
Non si tratta di errori o di ingenuità: insistere su tesi contraddette dall’evidenza; cambiare le parole, da mercato nero a economia informale; compensare con un fatto negativo opposto una notizia negativa che non si può tacere, anche se riguarda un regime di cui non si può parlare male: queste sono tecniche di manipolazione dell’informazione codificate nei manuali e applicate consapevolmente.
Cosa serve a Cuba e le radici della disinformazione
Ma cosa si aspetta davvero, Cuba, dietro queste mistificazioni? Cuba ha bisogno delle stesse cose che si tentò di fare in Unione sovietica tra il 1987 e il 1988: introdurre in modo guidato ma deciso l’iniziativa economica privata, che esiste già, ma è confinata a limiti troppo ristretti per salvare il Paese dal fallimento; passare a una società aperta che garantisca i diritti fondamentali e la partecipazione alla vita pubblica di tutte le componenti sociali.
In Unione sovietica, Gorbačëv fallì, per impreparazione sua e perché le riforme restarono ostaggio di un Partito unico privo di reali competenze in economia, diviso tra conservatori, riformatori e riformatori ma non troppo, dove ogni passo doveva essere giustificato dall’ideologia e dagli slogan. Bastarono pochi anni e non solo l’economia sovietica, ma lo Stato stesso crollò, nel 1991. In pieno inverno, Ucraina e Bielorussia rimasero senza gas e petrolio da riscaldamento, senza valuta per comprarli e senza crediti bancari per farsene prestare; in Russia e in tutta l’Unione mancavano cibo e lavoro, le famiglie rivendevano le vecchie bottiglie di vodka trovate in casa, per comprare i vestiti per i bambini.
Cuba è ferma da trent’anni su quel passo e non riesce a scollinare. Già allora, quando cadde l’Unione sovietica, si parlò di complotti americani, di cattiveria occidentale. Macché complotti: la popolazione era crollata, moralmente e materialmente, e si era tirata dietro il suo Stato. I complottisti ritornano: Cuba non funziona e la colpa è di tutti gli altri. L’unica differenza, rispetto ad allora, è che il COVID offre una scusa nuova.
Quanto all’informazione, poi, in particolare quella di lingua italiana: ci si può chiedere perché vengano diffusi prodotti giornalistici costruiti con le stesse tecniche propagandistiche usate dai notiziari degli Stati autoritari. Si può ricordare un dato storico: dal secondo Dopoguerra in poi, geopoliticamente, l’Italia ha fatto parte della NATO e del campo occidentale; culturalmente, però, era parte del sistema sovietico. Come per un tacito patto fra le parti, in un Paese che ha rischiato di scivolare nella guerra civile tra i due campi, le accademie e la macchina culturale nazionale erano controllate dal Partito comunista e dai suoi satelliti; faceva eccezione il circuito culturale della Chiesa cattolica, ma non era una gran consolazione.
A trent’anni dalla caduta dei regimi comunisti, in Italia questa situazione perdura e impedisce di entrare nei media che contano a chiunque non professi fedeltà a ciò che resta di quel sistema, che garantisce ancora oggi rendite di posizione, potere e celebrità. Ciò non basta, però: oggi, i regimi autoritari, dalla Russia alla Cina, dalla Siria alla Turchia, godono di copertura anche dal giornalismo di orientamento opposto, che non è migliore. Non basta contrapporre al giornalismo politicamente devoto a una parte, un altro giornalismo devoto al dio contrario. Un buon sistema d’informazione richiede ai suoi operatori capacità critica di analisi, sorretta da cultura e professionalità.
Manca, in Italia, un giornalismo professionale, nel senso che si dà a questo aggettivo negli altri Paesi occidentali. I pochi giornalisti che rispondono a questo requisito non fanno massa critica e vengono tenuti attentamente lontani dalle posizioni in cui potrebbero esercitare influenza. Scrivono sulle pagine di giornali meritori ma secondari – anche le maggiori testate, d’altra parte, ormai le leggono in pochi; fanno vitaccia da freelance finché non si stufano, poi o si adeguano o vanno a fare altro. Non li si vede mai in TV, lo strumento con il quale oggi si plasma l’opinione pubblica; li si trova su Internet, ma i loro profili, non sorretti da investimenti in post a pagamento e dalle scriteriate tecniche acchiappa-clic degli arrampicatori della Rete, restano orticelli per pochi.
Tornando, per concludere, a Cuba e alla sua crisi: l’economia pianificata, la proprietà statale dei mezzi di produzione e il regime a partito unico hanno mostrato tutti i loro limiti. Gli Stati che si ergevano a modelli di tale forma di governo sono falliti o hanno cambiato sistema, anche se qualcuno conserva la vecchia retorica. Dal passato si potrebbe imparare. Non hanno nessuna intenzione di farlo i governanti, attaccati ai loro seggiolini, immaginarsi certi cronisti.