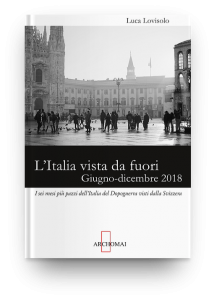Gli esiti della conferenza di Berlino sulla Libia si misureranno sui fatti. Perché questa volta potrebbe davvero cambiare qualcosa, a differenza dei precedenti tentativi di conciliazione. Qual è il ruolo dell’Europa e dell’Italia. In Libia si scontrano molti attori, ma oggi è chiaro chi domina il gioco. L’Italia avrebbe dovuto difendere a ogni costo la sua relazione con la Libia, ma non è stato così.
Gli esiti della conferenza di Berlino sulla Libia si misureranno, per quanto mi riguarda, sui fatti che la seguiranno. Il clamore giornalistico intorno all’evento è giusto, era una tappa importante. Per chi fa il mio lavoro, invece, conta piuttosto ciò che accadrà sul terreno, perciò bisogna attendere. S’impongono, però, alcune considerazioni, in particolare su tre punti: perché questa conferenza sulla Libia potrebbe davvero cambiare qualcosa, a differenza delle precedenti; il ruolo dell’Europa; la posizione dell’Italia.
La Conferenza di Berlino si è svolta in un contesto mutato, rispetto a quello degli analoghi consessi precedenti di Parigi e Palermo, caduti nel vuoto. Lo scenario è cambiato, in particolare, dopo l’impegno militare turco a fianco del governo legittimo di al-Sarraj. Ricordiamo che l’oppositore di al-Sarraj, il generale Haftar, controlla ormai buona parte del Paese fuori dalla capitale ed è sostenuto dalla Russia, oltre che da un manipolo di Stati arabi e da qualche Paese europeo dall’atteggiamento quanto meno ambiguo, come la Francia e la stessa Italia.
Perché questa volta è diverso
Nelle relazioni internazionali, le «soluzioni diplomatiche» non esistono, anche se questa dicitura piace molto ai retori dal sorriso facile. Una «soluzione diplomatica» è anche, sempre, una soluzione militare. Gli eserciti possono non sparare un sol colpo, ma se due parti in conflitto non hanno una credibile forza militare che funga da deterrente, o non hanno partner in grado di fornirla, nessuna «soluzione diplomatica» funzionerà mai. Sino al 1. gennaio di quest’anno, lo scontro, in Libia, riducendolo qui agli attori essenziali, era uno scontro Russia (cioè il generale Haftar) contro nessuno, cioè il povero al-Sarraj, legittimato dalle Nazioni unite ma al quale nessuno ha mai dato sostegno militare credibile e sufficiente.
Dal 2 gennaio 2020, giorno in cui il presidente turco Erdoğan ha ottenuto il voto favorevole del parlamento all’invio di truppe in Libia, il quadro è cambiato, anche se i militari turchi sono arrivati in misura minima. Oggi, lo scontro non è più Russia contro nessuno, ma Russia contro Turchia. Con il voto del parlamento turco è sorto in Libia uno scenario siriano: Turchia e Russia hanno interessi propri e talvolta divergenti sul terreno, ma si accordano secondo una metodica di Rational Choice (spiego cos’è in >questo articolo) affinché chi dei due deve rinunciare a qualcosa mantenga comunque una posizione che non lo renda totalmente perdente. Insieme, così minuettando, condominano il territorio.
Sul teatro libico si agitano molti attori, ma oggi è chiaro chi sono i dominus. Soprattutto, ambedue dispongono di un concreto deterrente militare: per paradossale che sembri, a queste condizioni una «soluzione diplomatica» può essere più facile da imporre di quanto lo fosse prima, su uno scenario privo di gerarchie chiare e di deterrenze reciproche. Staremo a vedere.
Il ruolo dell’Europa
Che la Conferenza si sia tenuta a Berlino salva le forme, ma non la sostanza. Chi dirigeva i giochi era chiaro sin dagli incontri bilaterali introduttivi: Putin ed Erdoğan, con una prevalenza del primo. Putin ha visto riconoscere il suo procuratore Haftar come interlocutore negoziale: ricordiamo che il governo legittimo libico è quello di al-Sarraj, perciò Haftar è un ribelle, per la comunità internazionale. Per la Russia, però, le regole non contano: nei prossimi giorni verrò alle modifiche costituzionali proposte da Putin la settimana scorsa, appena avrò finito di analizzarle come si deve. Spiegherò perché la Russia agisce e agirà sempre più in un ambito giuridico proprio, stabilendo da sola, à la carte, quali norme di convivenza internazionale applicare e quali no. Anche le motivazioni del suo impegno su terreni apparentemente lontani dalle sue orbite, come la Siria e la Libia, hanno un radicamento ideologico ben saldo, non è mera occupazione di zone d’influenza.
L’Europa e tutti i suoi Stati, che da soli non esistono più, anche se qualcuno non l’ha ancora capito, paga la disunità dei suoi membri, si sa. Paga anche dieci anni di politica estera e di sicurezza comune affidata a personalità scialbe e inesperte. E’ troppo presto per giudicare l’operato del nuovo Alto rappresentante europeo per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell. I presupposti del suo profilo sono ottimi, le capitali europee dovranno ora lasciarlo lavorare e dargli i poteri necessari: con le due precedenti commissarie, potevano dire di non fidarsi, oggi non hanno più scuse. Per il momento, il controllo sul terreno di uno degli Stati chiave per la sicurezza e l’approvvigionamento energetico di tutto il nostro Continente è nelle mani di due autocrati senza freni, mai così lanciati come oggi verso la vittoria culturale dell’autoritarismo che incarnano.
Il ruolo dell’Italia
Sentendo i notiziari italiani, che mettono sempre in scena una sorta di mondo parallelo a quello reale, la conferenza di Berlino avrebbe segnato la grande rentrée dell’Italia sullo scenario libico. Non è, visibilmente, il caso. In tutte le relazioni sulla Conferenza che ho udito e letto sui media internazionali, dell’Italia non vi è traccia. Può essermi sfuggito qualcosa, naturalmente, ma di certo a Berlino l’Italia non ha giocato il ruolo che le attribuiscono i media di Roma, ai quali il vincolo ideologico impone una reportistica sempre favorevole al governo attualmente in carica.
Per la verità, ho sentito un riferimento a Giuseppe Conte: nel consueto, leggero servizio «di costume» del telegiornale russo sulla conferenza berlinese, si notava con ironia che Putin, al momento della fotografia collettiva dei partecipanti, non si trovava. Si vedeva la signora Merkel che si girava di qua e di là, allungava il collo a destra e sinistra chiamando ad alta voce: «Vladimir Vladimirovič, Vladimir Vladimirovič!» Vladimir era in ritardo perché stava chiacchierando con Giuseppi. Se non fosse stato per questo episodio, la presenza italiana non sarebbe stata registrata.
L’Italia ha un ministro degli esteri che su tutte le situazioni sulle quali viene intervistato ripete formule polverose che sembrano imparate a memoria cinque minuti prima ed è espresso da un partito cresciuto all’ombra di Mosca; il capo del governo ha dalla sua, quanto meno, una preparazione giuridica e maggiore esperienza, ma entrambi gli uomini non sono interlocutori adatti alle sfide di oggi. Subiscono come due adolescenti la superiorità di Angela Merkel ed Emmanuel Macron, cosa diventino quando si trovano di fronte un Erdoğan, un Putin o uno Haftar, si può immaginare.
Tra la costa libica e il confine marittimo italiano vi sono 350 km. Quello, oggi, è il confine tra Italia e Russia, o tra Italia e Turchia, si può persino scegliere. Gli italiani non tarderanno ad accorgersene, quando si tratterà di negoziare con Ankara o con Mosca sugli interessi energetici essenziali per la Penisola in Libia, oppure sui flussi migratori. L’esperienza l’ha fatta la Germania, quando ha negoziato con Erdoğan per l’Europa il blocco di migranti sulla via balcanica. Per sapere come andrà ora su quella mediterranea, citofonare Merkel.
Conclusioni
Se il cessate-il-fuoco promesso a Berlino dalle parti libiche in conflitto sarà rispettato, ci si potrà rallegrare perché ci saranno meno morti, ma il quadro generale non è favorevole. In Libia c’è un governo riconosciuto dalla comunità internazionale, ma non lo si è sostenuto, anzi, a Berlino si è elevato a interlocutore negoziale un generale ribelle che si è imposto con la forza, spinto da potenze straniere, in aperta violazione dei principi di non ingerenza e integrità territoriale degli Stati, codificati nella Carta delle Nazioni unite.
Il controllo su un Paese in cui l’Europa e l’Italia hanno interessi vitali dipende oggi, nei fatti, da due autocrati che a Berlino hanno registrato un’ulteriore vittoria della loro visione retrograda, nazionalista e autoritaria del potere e delle relazioni internazionali, come se due Guerre mondiali e tutto ciò che è venuto dopo non ci fossero mai stati. L’Italia avrebbe dovuto difendere a ogni costo la sua relazione con la Libia, non in quanto banale zona d’influenza, ma per costruire con quel disastrato Paese una relazione fondata sulla salvaguardia degli interessi reciproci. Non è stato così.
L’opinione pubblica italiana è totalmente ignara di quanto la sua libertà e il suo benessere – sì, perché l’Italia è un Paese libero e benestante, chi pensa il contrario smetta di leggere qui – dipendano dagli sviluppi internazionali, oggi più che mai. Sui media si sentono e si leggono rubriche sugli esteri che oscillano tra il ridicolo e il patetico, anche sulle testate maggiori. Ci sono eccezioni, ma non fanno massa critica. Ora, la popolazione è impegnata a decidere se alcune dichiarazioni del nuovo presentatore del Festival di Sanremo siano o no sessiste, e, se sì, quanto.
Forse l’ho già scritto, in questo caso mi scuso per la ripetizione. Bisognerà svegliarsi con i russi in camera da letto, per capire come stanno le cose. Ma forse andrà bene così, e ci sarà chi godrà dei nuovi inquilini, e giù vodka e zakuski.